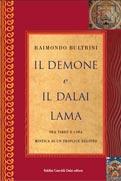 ll libro di Raimondo Bultrini “Il demone e il Dalai Lama” Editore: Baldini Castoldi Dalai, Di cosa parla il libro: “Il demone e il Dalai Lama”? Shugden, demone “feroce” del Pantheon tibetano nato nel 1600, ritorna, dopo secoli di oblio, a scatenare paure e tensioni tra la comunità tibetana esule in India. Alla morte del tredicesimo Dalai Lama, il suo culto riemerge per opporsi, attraverso una sorta di fratellanza massonica, alla tradizione del buddismo tibetano. … Dopo la fuga e l’esilio in India nel 1959, l’odierno Dalai Lama lo dichiara un culto “fondamentalista” e viene accusato dal governo di Pechino di violare, così, i diritti umani dei dissidenti. Un triplice delitto avvenuto a poche centinaia di metri dalla residenza in esilio del Dalai lama apre al commissario indiano Singh le porte di un universo che non conosceva. Assieme al suo vice Amithaba, ripercorre le fasi del brutale omicidio e identifica i colpevoli nei membri di un culto esclusivo dedicato a uno spirito dai temibili poteri mondani, Dorje Shugden. Ma i presunti assassini sono fuggiti in Tibet e i giudici non ritengono le prove raccolte sufficienti per punire i mandanti. Tra i principali sospetti, il vertice di una società ispirata a Shugden con sede nel quartiere degli esuli di Delhi. Al termine dell’istruttoria di polizia, un giornalista investigativo – l’autore – cerca di imboccare un percorso alternativo ricostruendo la mistica del triplice delitto. Il lama stava traducendo in cinese, assieme ai due monaci uccisi con lui, un testo del Buddha sull’Origine dipendente dei fenomeni. Il trattato sembrava indicare il filo da ripercorrere all’indietro fino alla causa originaria dell’odio e dell’incomprensione. Ma avrebbe fatto luce anche sui responsabili degli omicidi? Partendo dai risultati di Singh, un giornalista investigativo, l’autore, cerca allora di imboccare un percorso alternativo, ricostruendo la mistica che si cela dietro il crimine. La ricerca risale all’origine del culto nell’epoca del Quinto Dalai lama e di un suo contemporaneo che morì in circostanze mai chiarite nel grande monastero di Drepung alle porte di Lhasa. La leggenda della sua scomparsa e della successiva trasformazione in un essere demoniaco ha attraversato il tempo, per riaffiorare, di tanto in tanto, nelle fasi più cruciali della storia tibetana. L’attuale Dalai lama scoprirà da adulto che i suoi tutori e maestri avevano formato una coalizione di potere basata sul culto di Shugden fin dai tempi del suo predecessore, il XIII. Dopo aver a sua volta pregato per anni lo spirito su loro indicazione, progressivamente se ne distacca creando le condizioni per una sorta di scisma dagli esiti ancora imprevedibili. Deciso a combattere lo spirito settario coltivato in nome del demone da una parte del clero della sua scuola Gelupa, il leader tibetano rivela all’autore inediti particolari storici e religiosi sulle conseguenze del culto.
ll libro di Raimondo Bultrini “Il demone e il Dalai Lama” Editore: Baldini Castoldi Dalai, Di cosa parla il libro: “Il demone e il Dalai Lama”? Shugden, demone “feroce” del Pantheon tibetano nato nel 1600, ritorna, dopo secoli di oblio, a scatenare paure e tensioni tra la comunità tibetana esule in India. Alla morte del tredicesimo Dalai Lama, il suo culto riemerge per opporsi, attraverso una sorta di fratellanza massonica, alla tradizione del buddismo tibetano. … Dopo la fuga e l’esilio in India nel 1959, l’odierno Dalai Lama lo dichiara un culto “fondamentalista” e viene accusato dal governo di Pechino di violare, così, i diritti umani dei dissidenti. Un triplice delitto avvenuto a poche centinaia di metri dalla residenza in esilio del Dalai lama apre al commissario indiano Singh le porte di un universo che non conosceva. Assieme al suo vice Amithaba, ripercorre le fasi del brutale omicidio e identifica i colpevoli nei membri di un culto esclusivo dedicato a uno spirito dai temibili poteri mondani, Dorje Shugden. Ma i presunti assassini sono fuggiti in Tibet e i giudici non ritengono le prove raccolte sufficienti per punire i mandanti. Tra i principali sospetti, il vertice di una società ispirata a Shugden con sede nel quartiere degli esuli di Delhi. Al termine dell’istruttoria di polizia, un giornalista investigativo – l’autore – cerca di imboccare un percorso alternativo ricostruendo la mistica del triplice delitto. Il lama stava traducendo in cinese, assieme ai due monaci uccisi con lui, un testo del Buddha sull’Origine dipendente dei fenomeni. Il trattato sembrava indicare il filo da ripercorrere all’indietro fino alla causa originaria dell’odio e dell’incomprensione. Ma avrebbe fatto luce anche sui responsabili degli omicidi? Partendo dai risultati di Singh, un giornalista investigativo, l’autore, cerca allora di imboccare un percorso alternativo, ricostruendo la mistica che si cela dietro il crimine. La ricerca risale all’origine del culto nell’epoca del Quinto Dalai lama e di un suo contemporaneo che morì in circostanze mai chiarite nel grande monastero di Drepung alle porte di Lhasa. La leggenda della sua scomparsa e della successiva trasformazione in un essere demoniaco ha attraversato il tempo, per riaffiorare, di tanto in tanto, nelle fasi più cruciali della storia tibetana. L’attuale Dalai lama scoprirà da adulto che i suoi tutori e maestri avevano formato una coalizione di potere basata sul culto di Shugden fin dai tempi del suo predecessore, il XIII. Dopo aver a sua volta pregato per anni lo spirito su loro indicazione, progressivamente se ne distacca creando le condizioni per una sorta di scisma dagli esiti ancora imprevedibili. Deciso a combattere lo spirito settario coltivato in nome del demone da una parte del clero della sua scuola Gelupa, il leader tibetano rivela all’autore inediti particolari storici e religiosi sulle conseguenze del culto.
Molti degli eventi odierni sembrano dargli ragione, visto che i seguaci di Shugden sono entrati nell’area di influenza delle autorità cinesi. Il rapporto tra lama dissidenti e regime comunista si fa sempre più stretto, ponendo le basi per un’alleanza che punta a eliminare dal futuro del Tibet ogni traccia del lignaggio dei Dalai lama. Una sfida che coinvolgerà ancora parecchie generazioni di tibetani e cinesi, ma anche di occidentali interessati ai segreti delle civiltà dell’Asia.
Il rapporto tra lama dissidenti e regime comunista si fa ogni giorno più stretto, ponendo le basi per un’alleanza che punta a eliminare dal futuro del Tibet ogni traccia del lignaggio dei Dalai lama. La sfida è iniziata, e coinvolgerà ancora parecchie generazioni di tibetani e cinesi, ma anche di occidentali interessati ai segreti delle civiltà dell’Asia.
«Decine di lama, geshe, medium, studiosi e semplici praticanti, ai quali ho chiesto informazioni e pareri sul caso Shugden, mi hanno indistintamente pregato di raccontare i fatti con un atteggiamento imparziale perché ognuno potesse farsi da solo un’idea delle conseguenze cui potrebbe portare l’acuirsi dell’attuale tensione. In cima ai loro pensieri, la paura di veder accelerare attraverso le divisioni scolastiche la scomparsa di una cultura così particolare e profonda.»
Il Demone e il Dalai Lama nasce da qui. È il 4 febbraio del 1997. A un tiro di schioppo dalla residenza del Dalai Lama avviene un triplice omicidio: un monaco anziano e due novizi, impegnati nella traduzione di un testo buddista, vengono brutalmente assassinati. È l’inizio di un’indagine fitta di misteri, nel trambusto della moderna New Delhi, in cui il commissario di Polizia Singh, insieme a un reporter italiano che sta indagando parallelamente a lui, scoprirà di essersi imbattuto nel culto di Dorje Shugden. Sarà il Dalai Lama in persona, per anni devoto di Shugden prima di abbandonarlo, a introdurre il reporter nei meandri di un conflitto mistico che ha diviso diverse scuole del buddismo tantrico e condizionato segretamente la stessa storia del Tibet. (da www.unilibro.it)
Raimondo Bultrini, giornalista professionista dal 1979, ha lavorato all’«Unità» e a «Paese Sera», occupandosi di temi politici, giornalismo investigativo e denuncia sociale. Successivamente ha concentrato il suo interesse sulle filosofie orientali, sulle politiche asiatiche e sul buddhismo, diventando direttore delle riviste «Oriente» e «Merigar Letter». Dopo un anno trascorso in Cina e in Tibet seguendo il professore e maestro Choegyal Namkhai Norbu, ha scritto il libro In Tibet. Ha prodotto documentari per Samarcanda, Mixer, Format e La7 tra i quali La caduta del Muro di Pechino. Dal 2000 è collaboratore dal Sudest asiatico del gruppo editoriale la Repubblica/L’espresso e ha pubblicato oltre cinquecento articoli sull’Asia, seguendo gli eventi più importanti per «la Repubblica», « L’espresso», «il Venerdì», «Limes» e «D donna». Dopo l’11 settembre 2001 è stato inviato in Pakistan e Afghanistan. Nel 2002 ha diretto il film documentario Madre Teresa, una santa indiana. Fra le sue più importanti interviste, ci sono quelle effettuate nei numerosi incontri con il Dalai lama, VEDI https://www.sangye.it/dalailamanews/?s=Raimondo+Bultrini. Vive in Thailandia.
Tibet Lo spirito diabolico alleato della Cina contro il Dalai Lama
di Raimondo Bultrini, 08.02.08 La Repubblica.
BANGKOK – Il culto di uno spirito “feroce” dell’antica tradizione tibetana è tornato dopo secoli a scatenare paure e tensioni tra la comunità buddista esule. Un articolo pubblicato ieri dal China Daily ha anche riacceso attorno a questo misterioso essere dalle forme demoniche un’ ennesima polemica politica e religiosa tra il Dalai lama e le autorità di Pechino. Il Nobel della Pace è stato infatti accusato dal quotidiano comunista di “perseguitare” i seguaci dello spirito e di aver indetto un imbarazzante referendum nei monasteri buddisti in esilio per estromettere i religiosi che ancora venerano Dorje Shugden. Di questa controversa figura del pantheon himalayano, come il Voldemort di Harry Potter, molti temono perfino di pronunciare il nome, e non a caso nel 1997 ai seguaci di Shugden è stato attribuito il massacro a coltellate di un lama che aveva criticato aspramente il culto e di due suoi assistenti. Il giornale scrive che a seguito del “voto pubblico” nove monaci che si sono rifiutati di abiurare “Gyaiqen Xudain”, così è stato cinesizzato scaramanticamente il nome, sono stati espulsi “perché lo spirito è addirittura sospettato di compromettere la causa del Tibet e di danneggiare la salute del Dalai lama”. L’inedito interesse di Pechino per il rispetto delle libertà religiose e per la salute del leader esule risale a un episodio del 1996 citato nello stesso articolo. Quell’ anno un gruppo di buddisti tibetani e occidentali sfilò in corteo nel centro di Londra gridando slogan contro il Premio Nobel per aver chiesto “da un giorno all’ altro e senza motivazioni valide” di non pregare più il loro spirito. Il risalto dato dalla stampa occidentale e la successiva nascita di una “Coalizione Internazionale pro-Shugden” vennero seguiti con grande attenzione dai dirigenti di Pechino, ai quali non sembrò vero di trovare alleati tra gli ex discepoli del nemico “separatista” insignito del Nobel. I membri del culto hanno iniziato negli anni seguenti a ricevere speciali attenzioni e fondi per costruire statue di Shugden nei loro monasteri in Tibet, mentre un lama della coalizione residente in Italia, Ganchen Tulku, divenne uno dei più ascoltati consiglieri delle autorità cinesi nella delicata materia delle cosiddette “reincarnazioni”. Proprio la politica dei “tulku”, considerati capaci dopo la morte di riprendere forma a piacimento, sembra all’ origine di questo conflitto fatto risalire storicamente alla metà del 1600, quando il Quinto Dalai lama divenne il capo incontrastato della scuola dei Cappelli Gialli (i “Puri” Gelupa) che dominò per tre secoli il Tibet dall’ Himalaya ai confini cinesi. Lo spirito oggetto della controversia si sarebbe manifestato nel 1656 con il decesso in circostanze mai chiarite storicamente di un alto sacerdote della stessa scuola, Dragpa Gyaltsen, considerato dagli odierni seguaci il vero Quinto Dalai lama. Secondo questa tesi la figura di Dragpa Gyaltsen offuscava in termini dottrinari la figura del suo più celebre contemporaneo, ritenuto un “eretico” contaminato dalle pratiche di altre scuole. Da qui la presunta trasformazione post-mortem di Dragpa Gyaltsen in un “Protettore” divino del buddismo dalla forma feroce, con il compito di spaventare i nemici della fede (soprattutto gli adepti delle sètte diverse da quella Gelupa). Qualunque sia l’ origine del culto, di certo Shugden è riemerso dall’ oblio nel secolo scorso alla morte del XIII Dalai lama, quando un gruppo di alti sacerdoti, tra i quali i maestri dell’ attuale reincarnazione, riuscì a convincere gran parte della potente aristocrazia Gelupa di Lhasa che il potere della loro scuola derivava dalla “Protezione” di Shugden. Si creò così in suo nome una sorta di fratellanza massonica ai vertici del governo e lo stesso XIV Dalai, all’ epoca poco più che un bambino, venne “iniziato” al culto. Fu soltanto dopo la fuga e l’ esilio in India nel 1959 che l’ odierno Dalai lama, venuto a stretto contatto nel villaggio indiano di Dharamsala con i maestri delle altre scuole, considerò il culto di Shugden di natura settaria. O, come ci disse in un’ intervista, “fondamentalista”. Il premio Nobel ricevuto nella sua veste di leader di tutti i tibetani, senza distinzioni dottrinarie, lo convinse ad abbandonare definitivamente gli ortodossi e lo spirito da loro evocato come protettore esclusivo. Uno spirito che non a caso gli atei comunisti cinesi stanno cercando di riesumare e sostenere accusando il lama esule – come ha fatto ieri il China Daily – di “violare i diritti umani” dei praticanti di Shugden. La prossima mossa – già anticipata molti anni fa dall’ ex capo della provincia autonoma tibetana Qiangba Puncog – sarà quella di nominare a Pechino il prossimo Dalai lama, com’ è già successo con la figura numero due del buddhismo tibetano, il Panchen. Quello attuale è un ragazzo diciottenne, sostituito al candidato scelto a Dharamsala e sparito senza lasciare tracce dal 1995. Il primo lama a riconoscere il Panchen di Pechino fu proprio lo “shugdenista” Ganchen Tulku.
RAIMONDO BULTRINI http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2008/02/06/tibet-lo-spirito-diabolico-alleato-della-cina.html
Un’ombra sul tetto del mondo di Franco Marcoaldi, la Repubblica, 25/10/2008
Il fondamentalismo islamico rappresenta da anni il principale pericolo della convivenza planetaria. Del fondamentalismo induista si sente parlare sempre più spesso, per via dei massacri perpetrati contro i cristiani. Neppure ebraismo e cristianesimo possono dichiararsi indenni da febbri integraliste, anche se ovviamente di tutt’altra natura. Sin qui, l’unica religione che pareva non correre tale rischio era il buddhismo: ma si trattava di wishful thinking.
Ce lo dimostra Raimondo Bultrini nel suo libro Il demone e il Dalai Lama. Tra Tibet e Cina, mistica di un triplice delitto (pagg. 406, euro 18, Baldini Castoldi Dalai), che prende per l’ appunto avvio dall’uccisione di un lama e due monaci, avvenuta a Dharamsala (residenza indiana in esilio del Dalai Lama) il 4 febbraio 1997. Che l’episodio, dai vertiginosi rimandi storico-politici e teologico-mondani, non sia stato casuale e circoscritto, è dimostrato dai paralleli accadimenti incorsi in altre parti dell’Asia: nello Sri Lanka, il conflitto tra il governo della maggioranza buddhista cingalese e la minoranza tamil (di religione hindu), ha scatenato una guerra civile che ha già procurato settanta mila morti; mentre nel distretto di Preah Vihear è sorta addirittura una lotta fratricida armata tra i governi thai e cambogiano, entrambi di ispirazione buddhista, per il controllo di un tempio di epoca khmer.
Bultrini ricorda questi episodi sin dalla prima pagina e si chiede: «Perché predicare e dichiararsi seguaci di compassione e altruismo, se poi si fa uso delle armi e della violenza per affermare le proprie ragioni?». E’ una domanda che vale anche per le altre religioni, ma nel caso del buddhismo, sinonimo di dolcezza e quiete, l’interrogativo è più bruciante. In particolare per chi, come l’autore, simpatizza con questa nobilissima tradizione e con le sue pratiche tese a liberare la mente dai fantasmi che la abitano. Altri fantasmi però, altri spiriti, altri demoni incombono sul mondo buddhista, e segnatamente su quello tibetano, che a dispetto delle crescenti simpatie raccolte in ogni angolo del pianeta per i crimini patiti dall’imperialismo cinese, non appare affatto unito nella sua sacrosanta battaglia, né tanto meno indenne da diatribe interne via via più violente. E la chiave di volta per capire l’odio reciproco che sta montando tra le opposte fazioni, è rappresentata proprio da una «divinità-spirito-demone», che da secoli condiziona sotterraneamente la vita religiosa e conseguentemente politica del Paese delle Nevi: Dorje Shugden.
Ora, tra le diverse tradizioni buddhiste, quella tibetana (innestatasi sul precedente sciamanesimo bon) è circondata forse più di ogni altra dall’aura della magia e del portentoso. Dunque, per cercare di penetrare in tale misterioso universo, bisognerà abbandonare ogni iperrazionalismo, ogni ardore antropocentrico, e provare a immaginare che sul tetto del mondo, nei suoi spazi sublimi e infiniti, l’individuo è ridotto a uno shakespeariano «sogno di un¿ombra». Ecco perché Shugden – per alcuni un protettore, per altri il diavolo – può condizionare così prepotentemente la vita collettiva e il destino di ciascuno.
Lo stesso Dalai Lama, un tempo suo fervente seguace, lo elesse all’importantissimo rango di “vice” Oracolo di Stato.
Successivamente però, resosi conto del suo maligno influsso, ne rinnegò il valore, imponendo severissime restrizioni al suo culto: in quanto protettore esclusivo della tradizione Gelupa, Shugden alimentava settarismo e integralismo, impedendo il dialogo con altre scuole e componenti della comunità religiosa tibetana. A cominciare dalla tradizione dei Nymapa.
Questa netta presa di posizione, che incide tanto sul sedimentato mondo delle credenze popolari, quanto sulla geografia del potere religioso, avrà conseguenze impensate. E aprirà una stagione di lotta sempre più cruenta nel mondo tibetano: i seguaci di Shugden insorgono contro il Dalai Lama, accusandolo di farsi bello nel mondo con parole di ecumenismo e pace, mentre impedisce la libertà religiosa dei suoi stessi fratelli. E nello stesso Occidente, fatto ben più sorprendente, si moltiplicano le manifestazioni contro Sua Santità, alimentate da comunità a lui avverse che godono di un crescente afflusso di denaro straniero. I toni si inaspriscono; la violenza verbale, e non solo verbale, cresce. E in questo clima matura il triplice omicidio di Dharamsala.
Quanto alle autorità di Pechino, ovviamente, gongolano. Dopo l’impropria investitura di un nuovo Panchen lama gradito al Partito, spingono la seconda autorità religiosa tibetana a sponsorizzare in modo sempre più stretto Shugden e i suoi adepti: la strategia di accerchiamento del Dalai Lama può contare così su nuove, affilatissime armi. Insomma, una vicenda le cui origini affondano in lontane e oscure diatribe mistiche, ha finito per infiltrarsi pesantemente nella scabra e fangosa trama del potere mondano.
L’abilità di Bultrini consiste proprio nella capacità di tenere assieme uniti e distinti due registri tanto diversi tra loro. E per riuscire in tale intento, mette in campo una scrittura quanto mai variegata, nella quale si combinano il racconto e le interviste (tra cui quelle, ripetute, al Dalai Lama), pagine di saggismo storico e riflessioni autobiografiche sul mestiere del reporter investigativo. Ma, al fondo, l’urgenza che motiva tale impervia ricerca è una sola: quella di un amico del buddhismo tibetano che con immensa preoccupazione vede svilupparsi, tra i fratelli di una stessa fede, un conflitto che di primo acchito può risultare incomprensibile agli occhi di un occidentale comune. «Ma proprio risalendo alle radici dell’odio che sta lacerando profondamente la comunità tibetana dentro e fuori il Paese delle Nevi, diventa evidente il paradosso che ha spinto e spinge gli eredi dei grandi insegnamenti esoterici ad accelerare il proprio declino, forse la stessa estinzione di una delle più antiche e straordinarie culture del pianeta».
http://ilmiolibro.kataweb.it/booknews_dettaglio_recensione.asp?id_contenuto=3380949
Me ne sono ricordata leggendo, in questi giorni, Il demone e il Dalai lama di Bultrini. Racconta una storia vera, l’omicidio di tre monaci tibetani in esilio in India nel 1997.
Per farla “breve”, nel 17 secolo è stata creata una diversa visione e modo di meditare, basate su un demone dal nome Dorje Shugden. Da giovane, ancora sotto la tutela del reggente, ci aveva creduto anche l’attuale Dalai lama, ma poi ha disconosciuto il demone, ammettendo la verità già compresa da un Dalai lama precedente (mi pare il quinto?) che lo aveva esorcizzato con un potente rituale del fuoco. Ma la tradizione continua, perché si crede che i poteri di questo spirito ti elevino ad un livello uguale o superiore a quello del Buddha. E’ una scuola diffusissima, anche in Europa e USA (il monastero qui vicino, sul Matajur, appena prima di entrare in Slovenia, ad esempio, è di questa scuola). Si chiama anche scuola del Libro giallo. I fedeli del Libro giallo dicono che Shugden non è uno spirito, ma la reincarnazione di non ricordo quale altro buddha.
I tibetani sono divisi, in sostanza. E la Cina ci ha visto la sua grande opportunità per entrare in Tibet anche religiosamente e quindi politicamente. Non basta più l’emigrazione forzata di cinesi in Tibet, non basta più usare il Tibet come discarica per rifiuti radioattivi, non basta più voler decidere chi sarà la nuova reincarnazione del dalai lama. Chi ha sempre considerato la religione una sovrastruttura inutile, l’oppio dei popoli e balle verie, entra nell’intimo delle persone proprio attraverso la religione.
Dorje Shugden non può essere esorcizzato, perché è un’invenzione. E infatti dargli una forma corporale attraverso la reincarnazione non è servito a rafforzarlo, è stato solo un’espediente. Il culto di Dorje Shugden è usato a scopi politici.
Shugden, il Lama demoniaco uccide ancora di Ugo Leonzio
Fate male a non credere ai demoni e a tutto il meticoloso corteo di membri dell’invisibile che ci accompagna mentre noi li scrutiamo senza vederli. Se non credete ai demoni lasciate perdere questa storia, è una delle più violente e intricate mai prodotte dal potere del misticismo. Ma se li percepite, avvertendo in questo autunno un delicato mantice di gelo intorno agli occhi e alle narici allora non potete sottrarvi al privilegio di penetrare nella storia tenebrosa di uno spirito che sta sgretolando il Tibet. I più ricercati tra questi demoni si trovano nei remoti orienti e tra questi i più pregiati sonnecchiano in qualche gelida landa tibetana, nei deserti del Chang Tang o tra i canyons dello Shang Shung. Ma se non volete impegnarvi in camminate faticose dormendo in grotte dove manca perfino una doccia calda, dirigetevi verso qualche rinomato gompa a Dharamsala, in India, dove il Dalai Lama, la sua corte di lama, oracoli, monaci e una colorata miriade di pellegrini occidentali hanno trovato una casa. Se per un giorno vi metterete un nastro di crespo sul cappello e vagabonderete tra i vicoli e le stradine sfuggenti, di sicuro li incontrerete. È probabile però che i vicoli intirizziti e l’altitudine (i demoni hanno sempre a che fare con con l’altitudine) vi procurino un brutto raffreddore, allora investite diciotto euro, sistematevi davanti a una teiera bollente e leggetevi il libro di Raimondo Bultrini: Il demone e il Dalai Lama (Baldini Castoldi Dalai ed.). Quando, a pagina 30, Dorje Shugden, il più glamour dei demoni e degli oracoli tibetani si impadronirà inesorabilmente di voi, lasciatevi scivolare nel suo mondo senza resistere. La sua storia potrebbe stare in due righe. Torniamo a quattro secoli fa, Allora Shugden si chiamava Dragpa Gyaltsen, era il più vertiginoso lama del vertiginoso convento di Drepung e la sua fama oscurava quella del Dalai Lama che ne soffriva e che usò il suo potere. Dragpa Gyaltsen fu umiliato, beffato, degradato e finì per morire in circostanze misteriose, soffocato con una sciarpa di seta ficcata in gola. Era l’estate del 1656, tredici di luglio. Un’estate stranamente calda. Gyaltsen aveva appena compiuto trentotto anni. La sua trasformazione in Dorje Shugden, l’oracolo-demone che ruba il sonno ai Dalai Lama, fu immediata come il culto che coinvolse i lama più brillanti, colti e vicini al potere. Shugden è un oracolo mondano, conferisce fortuna e procura benefici a chi lo venera ma sventure a chi lo rifiuta… La sua fama è esplosa il 4 febbraio 1997, quando a Dahramsala un triplice delitto, compiuto in onore di Shugden, sfiora la persona del Dalai Lama. I tre lama appartengono alla stretta cerchia dei suoi più intimi collaboratori. Il demone e il Dalai Lama comincia da qui. Rivelare l’essenza di Shugden però è tutta un’altra faccenda. Si deve scendere nei più intimi recessi della storia del Tibet. La sua qualità di protettore e seduttore delle menti mistiche più prelibate fa in modo che le sue storie ne contengono un’infinità di altre e inseguendole si finisce per scendere in una cantina polverosa e dimenticata, custodita da ragni sapienti, piena di casse, faldoni, archivi, mantra, documenti, preghiere, libri ancora intrisi di sangue scuro e rappreso ma pronto a brillare di nuovo nelle ombre e nelle penombre. Associando la spiritualià al sangue, Bultrini ci mostra lo spazio in cui nasce e si agita pericolosamente il motivo mondano di Dorje Shbugden e dei suoi devoti, il potere della spiritualità e la spiritualità del potere. Più inquietante quest’ultima, perché purifica in modo apparente e seducente il lato demoniaco della nostra natura legandola pericolosamente all’invisibile e all’inconscio che lo contiene. Per rivelarne l’essenza tenebrosa Bultrini crea un’indagine poliziesca che insegua gli assassini e ne sveli la paurosa l’identità. Ma la caccia è a Shugden. Non è uno sviluppo graduale ma un vagabondaggio tra ombre e intuizioni, in un accumulo progressivo di materiali, memorie, fatti, documenti, voci, personaggi che lentamente delineano, come un paesaggio che esca da una fitta nebbia, il mondo tibetano, la sua storia, il suo fascino, le sue debolezze. L’ispettore Rajeev Kumar Singh e il suo grigio assistente girano in tondo senza sapere veramente cosa cercare. Il movente è oscuro. Cosa c’è di umano, corrotto, crudele in questo delitto? I corpi straziati e dissanguati sono l’irruzione dell’invisibile nella vita quotidiana? O è solo una questione di denaro e potere che coinvolge tutti, tibetani, cinesi e occidentali devotamente indemoniati? Dove si nasconde il mandante, il protettore, la guardia, il demone? E, alla fine, cos’è un demone? Se amate la musica potreste farvene un’idea ascoltando l’ultimo movimento del Quartetto op. 5 di Anton Webern. Sono quattro minuti molto, molto istruttivi (evitare le ore notturne…). I documenti, i personaggi, le prove si infittiscono pagina dopo pagina, prima in modo apparentemente disordinato poi facendo emergere un disegno assai più implacabile e inquietante di quanto il triplice omicidio, all’inizio, potesse far pensare. Cosa si trova alla fine di questa formidabile, perfetta indagine che nel suo vagabondare nei meandri più profondi e indiscreti non solo della storia tibetana ma della sua psiche, spazza via tutta l’esausta, ansimante letteratura della «città proibita» e degli «orizzonti perduti» (esempi recenti: Peter Hopkirk, Alla conquista di Lhasa, Adelphi, e John Snelling, Il Monte sacro, il Saggiatore) per mostrarci le fantastiche crudeli metamorfosi del potere che dominano il mondo invisibile del misticismo? Il sangue su rapprende, l’indagine finisce, gli assassini svaniscono, le vittime diventano cenere. E Dorje Shugden, il demone, eterno rivelatore della fragilità umana? L’oracolo geloso, sofferente, vendicativo? Ci segue, forse ci insegue con le sue pulsioni nude, spirituali, primordiali. Quello che resta di noi, dopo la morte.17 ottobre 2008 http://cerca.unita.it/ARCHIVE/xml/280000/275456.xml?key=Ugo+Leonzio&first=11&orderby=1&f=fir
Nel numero di ieri di Notizie Radicali abbiamo recensito Il demone e il Dalai Lama di Raimondo Bultrini, edito da Baldini Castaldi Dalai (€ 18,00).
Nelle quattrocento pagine dell’opera si amalgamano con intelligenza e notevole raffinatezza narrativa, saggistica, indagine giornalistica.
Si parte da Dharamsala, nell’India settentrionale dell’Himachal Pradesh, dove dagli inizi degli anni sessanta si è insediata, al seguito del Dalai Lama, la più numerosa comunità di esuli tibetani scampati, con fughe rocambolesche tra le innevate altitudini himalayane, alla devastante colonizzazione cinese per addentrarsi gradualmente nella storia dell’antico Tibet e tra le pieghe del buddhismo sviluppatosi, dall’VIII secolo d.C., nel Paese delle Nevi. E’ un viaggio intrigante e affascinante alla ricerca della genesi di una controversia religiosa che, nel corso del tempo, ha finito per assumere, a causa delle ingerenze neppure poi tanto tacite della Cina, forti connotati politici.
Lo spunto è dato dal triplice, feroce, assassinio, avvenuto il 4 febbraio 1997, alla vigilia del Losar, capodanno tibetano, nel villaggio di Mc Leod Ganj, nella sommità di Dharamsala, a pochi metri dalla Scuola di dialettica e dalla residenza del Dalai Lama. Un autorevole lama Lobsang Gyatso viene trucidato nella sua stanzetta, insieme a due giovani monaci traduttori Lobsang Ngawang e Ngawang Lodoe. La scena che si offre a Rajeev Kumar Singh, il sovrintendente di polizia incaricato di seguire il caso, e al suo collaboratore Amithaba è a dir poco raccapricciante.
Sin dalle prime battute dell’indagine si evince che un delitto così efferato debba rispondere ad un preciso disegno criminale. Dall’intricato quadro che a poco a poco si delinea emerge che si tratta di una ritorsione compiuta da sicari di una setta dedita al culto di Dorje Shugden, sorta di demone venerato da fondamentalisti e duramente criticato, proprio per i suoi connotati negativi, dal Dalai Lama che ne ha fermamente sconsigliato i rituali. Superfluo aggiungere che la setta agguerrita e bene organizzata, con diverse propaggini in occidente, gode dei favori del governo cinese pronto, come si sa, a sfruttare qualsiasi occasione pur di colpire il Dalai Lama e seminare opportunisticamente confusione e dissidio tra gli stessi tibetani.
Dal momento che nel testo vengono trattati temi molto delicati e interessanti abbiamo raggiunto Raimondo Bultrini per approfondirli. Ne è scaturita un’intervista particolarmente ampia che sicuramente potrà essere di giovamento non solo a quanti, affascinati dal buddhismo tibetano, vorrebbero saperne di più, al di là di tante approssimazioni, ma anche a coloro che seguono con partecipazione le vicende politiche del Tetto del Mondo e rivolgono costante attenzione alla via nonviolenta proposta da Tenzin Gyatso, S.S. il XIV Dalai Lama, insignito nel 1989 del premio Nobel per la pace.
1) Innanzitutto partiamo dal sottotitolo:“tra Tibet e Cina mistica di un triplice delitto”. Che tipo di mistica può celarsi dietro un atto criminoso?
Raimondo Bultrini. Il triplice delitto del 4 febbraio 1997 di fronte alla residenza del Dalai lama non è stato per la comunità tibetana un semplice atto criminoso. Anche paragonarlo a un assassinio politico o religioso – nel senso di guerra tra chiese o correnti clericali – può essere riduttivo. Ho usato il termine “mistica” per sottolineare il concetto religioso arcaico di ‘mistero’, che sia nel latino mysterium sia nel greco musteria indica una dimensione non tanto misteriosa quanto iniziatica, prerogativa di individui istruiti – ovvero iniziati – a certi culti della meditazione trascendentale (collegati nel cristianesimo a Dio o a entità divine in generale, mentre nel buddhismo tantrico i poteri della mente umana possono collegarsi a diversi tipi di essere, non necessariamente di natura divina). ‘Mistico’ equivale al segreto, imperscrutabile universo impossibile da descrivere attraverso analisi filosofiche, psicologiche o razionali. Col tempo i seguaci di un certo tipo di osservazione o auto-osservazione dei fenomeni inconsueti derivati dai poteri della mente hanno creato, a partire dal nostro medioevo, una tendenza definita del “libero spirito”, contraria alle regole stesse della società e della chiesa. Mentre in Occidente certi movimenti e i loro rappresentanti dovevano ancora finire sotto il maglio dell’Inquisizione, in Tibet erano sorte già nell’anno 1000 nuove scuole religiose contrapposte a quelle dei “mistici” ante literam, seguaci dei primi insegnamenti tantrici buddhisti del grande maestro indiano Padmasambhava. Certi esercizi e tecniche yoga finalizzati a separare – ad esempio – la mente naturale dalla mente razionale prevedevano la totale assenza del controllo psichico ordinario, l’uso di movimenti “scomposti”, di mantra acuti e potenti, e per questo venivano praticati in luoghi isolati. La scuola dei New Kadampa di Atisha e successivamente la Scuola dei Virtuosi (I Gelupa, o Cappelli gialli) sono sorte proprio per contrastare le tendenze tantriche (principalmente mistiche) della Scuola antica Nymapa fondata da Padmasambhava e associate spregiativamente allo sciamanesimo del Bön. Ma mentre i mistici che praticavano in caverne e luoghi remoti avevano come fondamento lo sviluppo individuale della bodhicitta, il seme della compassione e dell’altruismo universale, gran parte delle scuole organizzate gerarchicamente hanno finito per trasformarsi in una sorta di Stato nello Stato. Per secoli le tradizioni Sakyapa, Kajupa, Kadampa e Gelupa hanno lottato per la supremazia non solo religiosa ma anche politica, indicando al popolo etiche comportamentali, curriculum monastici, devozione ai rituali comunemente accettati e ai maestri in linea con i principi fondatori, spesso agendo come un qualsiasi governo laico e usando la spietata logica della “ragion di Stato” per dirimere controversie e epurare eventuali “eretici”.
Nel caso del triplice omicidio preso in esame nel libro (con tutti i precedenti delitti “politici” commessi nei secoli) si vanno a mischiare e condensare numerosi aspetti della cultura e della tradizione mistica e filosofica tibetana, laddove il termine “mistica” è alternativo a quello di “logica” o “filosofia”. Mistica e logica sono due cose diverse e separate dallo stesso diaframma che divide il noto dall’ignoto, la mente che osserva e riflette dalla mente che si lascia attrarre dal riflesso e giudica costantemente. Quindi, anche se non credo di poter spiegare in poche righe come mai attribuisco il termine “mistico” a un triplice omicidio, invito ogni eventuale lettore a entrare nella “logica misterica” che pervade la storia di questo culto, che risale a tre secoli e mezzo fa, ma appartiene nella sua essenza all’archetipico conflitto tra Bene e Male, comune a diverse religioni e credenze. Va da sé comunque che l’uso dei concetti di filosofia e di mistica è fortemente condizionato in Occidente dal nostro passato storico. Per questo bisogna entrare nella storia “segreta” del Tibet per capire molte cose apparentemente inspiegabili, legate una all’altra da fili sottili che percorrono il tempo e lo spazio. Riflettendoci ora, avrei potuto usare il termine “karma di un triplice omicidio”. Ma saremmo stati daccapo: quanti conoscono l’esatta definizione di karma?
2) Il tuo libro non solo affronta un argomento decisamente difficile, complesso, finora poco approfondito, ma sembra soprattutto mettere in evidenza la gravissima contraddittorietà di posizioni fondamentaliste all’interno di una visione aperta e tollerante per antonomasia come quella buddhista. Nell’introduzione, in particolare, riferendoti espressamente a situazioni da te stesso verificate nello Sri Lanka o al confine tra Cambogia e Thailandia scrivi: “Lo spirito della discordia alimentato da interessi mondani è teoricamente agli antipodi dell’insegnamento trasmesso oltre due millenni fa del Buddha”. E, subito dopo, ti chiedi non senza una venatura di amarezza: “Perché predicare e dichiararsi seguaci dei principi di compassione e altruismo, se poi si fa uso delle armi e della violenza per affermare le proprie ragioni?”
Raimondo Bultrini. Si dice che “il fine giustifica i mezzi” quando si ritiene che l’obiettivo finale sarà migliore dello status quo (precedente all’utilizzo di metodi prevedibilmente violenti o illeciti). I buddhisti cingalesi dello Sri Lanka ritengono che il massacro delle popolazioni tamil sia necessario per estirpare il fenomeno terrorista del LTTE, terminato il quale regnerà – dicono – una pace duratura e stabile. Di certo i tamil non terroristi (generalmente di fede hindu) temono fortemente questa futura “pace” basata sul predominio dei cingalesi. Non solo e tanto perché si tratta di una diversa etnia che pratica una diversa fede religiosa. Ma perché i governanti e gli stessi leader buddhisti cingalesi hanno dimostrato di saper essere spietati e crudeli senza saper al contempo isolare la minoranza fondamentalista-terrorista e salvaguardare gli interessi del resto della popolazione pacifica. E’ quindi la mancanza di chiarezza che deriva dalla distorsione dei principi di compassione a essere responsabile delle degenerazioni ammantate in vesti dottrinarie. Nel libro cerco di indicare durante la storia del Tibet (e non solo quella connessa alle vicende del gyalpo Shugden) i momenti nei quali la vera bodhicitta, intesa come comprensione del ciclo originario di sofferenza e relativa liberazione comune a tutti gli esseri, è stata sostituita o “reinterpretata” da cosiddetti Maestri che avevano un’influenza politica o erano essi stessi governanti. Costoro usavano la fede nella dottrina (Kadampa, Gelupa o altre) , o la dottrina della fede, come un’arma di liberazione finale, senza considerare che nessuna liberazione individuale o di gruppo può prescindere dalla contemporanea liberazione di tutti gli altri esseri ancora intrappolati nel samsara. Considerando che potremmo essere stati tutti fratelli, madri o figli in qualche altra vita, come potremmo abbandonare i nostri simili dentro una casa in fiamme senza tentare di spegnere il fuoco che la divora? Certo non è facile: non tutti possono seguire la Via dei bodhisattva. Ma quando si sostiene di seguire la dottrina del Buddha, bisogna sapere che cosa il Maestro ha insegnato: “quando non sappiamo come aiutare gli altri – ha detto Sakyamuni – almeno non disturbiamoli.
3) Quando hai cominciato ad interessarti al buddhismo? Come è avvenuto l’incontro con un maestro come Namkhai Norbu cui si deve l’insegnamento anche in occidente dello Dzogchen? Con lui ti sei recato nel 1988 fino al mitico Monte Kailash e da quel viaggio hai ricavato una testimonianza molto interessante, “In Tibet”, pubblicata purtroppo in un’edizione limitata…
Raimondo Bultrini. In realtà ho iniziato a interessarmi al metodo migliore per aiutare la mia mente sofferente prima che al buddhismo. Ho approfondito Confucio e Lao Tsu, i mistici cristiani, perfino l’antropologo Castaneda e gli strani affascinanti insegnamenti attribuiti al suo bruco tolteco don Juan. Ovunque frammenti di verità placavano temporaneamente e parzialmente l’ansia e il dolore creati dalle contraddizioni tra la mia volontà di vivere serenamente senza danneggiare il prossimo e la realtà, creata dal mio egoismo e dalla mia ignoranza di una verità che potesse eventualmente sovrintendere tutte le altre. Dopo essere cresciuto appellandomi da cattolico all’aiuto di un’entità divina esterna, con la maturità avevo smesso di pregarla per il principale motivo che chiedere aiuto a un Dio creatore di cose belle ma anche terribili come guerre, malattie e disastri mi sembrava una contraddizione.
Quando incontrai Chogyal Namkhai Norbu nel 1986 non sapevo nulla del buddhismo, men che meno di quello tibetano. Sostanzialmente scoprii grazie a lui che i praticanti tantrici si ponevano le mie stesse domande, e che la sofferenza mentale non era solo la causa ma anche l’effetto della nostra ignoranza. Nessuno delle migliaia di libri letti fin dalla mia infanzia poteva nemmeno lontanamente compararsi a una lezione di quel maestro. Ci volle un po’ per capire che lo Dzogchen, o Grande Perfezione, era basato sull’esperienza e non sulla conoscenza intellettuale, e che la stessa associazione dello Dzogchen alle tradizionali scuole del buddhismo tibetano era in un certo senso impropria, trattandosi di una Via di autoliberazione priva di comandamenti e regole dottrinarie. Gli insegnamenti erano per lo più testimonianze di altri praticanti e maestri, o “Testamenti”, come quelli del celebre – e in Occidente semisconosciuto – Garab Dorje. La necessità del maestro come guida non viene intesa nello Dzogchen come pre-condizione per sviluppare una pura devozione, ma come simbolo vivente della natura pura e incontaminata della propria mente. Il maestro possiede quella saggezza che nello Dzogchen viene associata al simbolo dello specchio: la mente allo stato primordiale, puro e incontaminato, riflette senza venire condizionata dal riflesso. Una montagna, un Buddha o un cane hanno la stessa natura del Vuoto da cui origina ogni fenomeno. Attaccarsi al riflesso – che pure esiste, è apparentemente materiale, concreto e non va sottovalutato – significa attaccarsi anche alla sofferenza che deriva dal perdere ciò che si ha, o si crede di avere.
4) Quando hai preso davvero coscienza della drammaticità della condizione tibetana?
Raimondo Bultrini. E’ successo durante un viaggio del 1988 raccontato in parte nel libretto In Tibet che hai citato. Laddove attraversavo montagne incantevoli disseminate di piccoli villaggi e gruppi di tende di nomadi tibetani, avvertivo la pace di quei luoghi e il potere emanato dal rispetto che quella gente aveva dell’ambiente attorno. Laddove invece c’erano insediamenti cinesi, l’obbrobrio degli edifici, le attività di escavazione, di costruzione e il generale atteggiamento dei coloni verso la popolazione indigena erano manifestamente fastidiosi, a cominciare dagli altoparlanti che trasmettevano mattina e sera annunci politici e “parole d’ordine” del partito. I cinesi dicevano di portare il benessere e di estirpare i residui di feudalesimo dell’antica società tibetana. Ma a parte alcuni tibetani che hanno sposato la causa degli invasori, il resto della popolazione disprezzava i metodi cinesi in tutte le loro forme. Ho sentito testimonianze di crudeltà inaudite, come quando durante la rivoluzione culturale le teste dei dissidenti venivano allineate sulla strada per essere schiacciate dalle ruote dei camion e risparmiare così proiettili. Violenze analoghe sono accadute anche dopo le rivolte di Lhasa del marzo scorso. Ma per parlare di cose meno cruente, un giorno, mentre mi trovavo in un tempio di Khamdogar in Chamdo, a due giorni di cavallo dalla strada più vicina, sono arrivati dei tibetani al servizio dei cinesi e hanno interrotto la cerimonia religiosa per controllare i miei permessi. Nonostante fossero regolari, volevano allontanarmi, e solo dopo una lunga discussione alla quale ha partecipato quasi l’intero villaggio se ne sono andati.
5) Proprio Namkhai Norbu, come hai scritto, sostiene che Dorje Shugden sia un “gyalpo”…
Raimondo Bultrini. Infatti Norbu lo chiama Gyalpo Shugden, e il Dalai lama usa l’espressione Gyalchen, o grande gyalpo. E’ una delle classi di esseri che, come gli uomini, può avere secondo i tibetani valenze buone o cattive, dipende dai singoli individui e dal loro karma, frutto delle loro azioni precedenti. Dicono gli antichi saggi che un attimo di rabbia distrugge i meriti accumulati dopo eoni ed eoni passati a compiere azioni positive. Vale per gli uomini e per gli esseri non umani. Uno dei Gyalpo più famosi è Pe har, il “Protettore” divino del quale è considerato emanazione l’Oracolo di Stato del Tibet Nechung. Pe har – secondo la tradizione mistica tibetana – era un essere feroce e potente che fu sottomesso all’ubbidienza verso il dharma buddhista da Padmasambhava. Invece di ucciderlo come avrebbe potuto grazie ai poteri di maestro dei tantra, Padmasambhava trasformò le sue enormi potenzialità mettendole al servizio della religione. Ma evidentemente la classe di gyalpo cui appartiene Shugden è meno domabile. O quantomeno la sua influenza ha condizionato un numero abbastanza consistente di devoti incapaci di liberarsi dalla dipendenza da questo culto.
6) Al di là degli aspetti religiosi, dietro il culto di Shugden si sono storicamente celati interessi politici. Dietro la scusa di privilegiare l’insegnamento dei gelupa e la cosiddetta via graduale all’illuminazione c’era, in realtà, la volontà di conservare un sistema sociale di cui una figura come il Tredicesimo Dalai Lama avvertiva fortemente l’esigenza di una radicale riforma. Sia il Quinto che il Tredicesimo Dalai Lama, come d’altronde l’attuale, il Quattordicesimo, hanno avversato privilegi e concezioni del potere verticistiche e feudali…
Raimondo Bultrini. Ritengo che Shugden, come i vari Dalai lama che si sono succeduti sul trono del Tibet, abbiano agito ognuno secondo le proprie tendenze in momenti storici particolari. Forse è eccessivo paragonare il V o il XIII Dalai lama a esponenti democratici e riformisti come li intendiamo oggi in Occidente. Perché l’attuale Dalai lama potesse rendersi conto dei progressi di certi sistemi politici e sociali laici c’è voluto l’esilio, sebbene fosse già consapevole da ragazzo delle enormi discriminazioni patite in Tibet da molti suoi sudditi oppressi da una certa aristocrazia feudale. Ma guarda caso uno degli ostacoli più pesanti alla sua missione di riformatore fin dai tempi del suo governo al Potala veniva proprio dalla Corte di tradizionalisti gelupa devoti al culto di Shugden. E lo stesso accadde sotto il XIII, mentre per il periodo del V Dalai lama abbiamo troppo poche referenze storiche per capire se davvero la sua personale apertura ecumenica alle altre tradizioni buddhiste corrispondesse anche a una maggiore giustizia sociale e apertura religiosa. Di certo i rapporti con il capo della scuola kajupa, non erano idilliaci e furono ristabiliti solo poco prima della morte del Karmapa.
7) Ad un certo punto fai riferimento a un misterioso “libro giallo” scritto negli anni Settanta da Zemey Rinpoche e forse ispirato da Trijang, devoto del terribile spirito ma anche uno dei tutori dell’odierno Dalai Lama. Di che si tratta con precisione?
Raimondo Bultrini. Il libro giallo elenca con dettagli – solo in parte dimostrabili storicamente – la sorte di alcuni importanti lama e alti dignitari tibetani che, dopo un passato di devoti della tradizione Gelupa e del culto di Shugden, sarebbero caduti in disgrazia – secondo il libro – per aver iniziato a praticare anche gli insegnamenti di altre tradizioni, in particolare dell’antica scuola nymapa e dello Dzogchen. Un celebre maestro nymapa ancora vivente, Chadral Rinpoche, ha contestato uno per uno tutti gli esempi riferiti da Zemey. Ma al di là della validità di affermazioni indimostrabili (come si può attribuire un incidente, una malattia o una sconfitta politica a uno spirito maligno anziché ad altre cause molto più plausibili?) nel mio testo metto in evidenza un episodio accaduto a Dharamsala dopo la pubblicazione del Libro giallo e considerato dal Dalai lama all’origine della sua decisione di sconsigliare pubblicamente il culto di Shugden. In pratica monaci e monache che avevano letto le storie citate da Zemey nel libro si rifiutarono di partecipare a una cerimonia religiosa promossa dal leader tibetano in onore di Padmasambhava. Questo grande maestro dell’VIII secolo è infatti considerato pressappoco il nemico numero uno della dottrina religiosa gelupa, per via dei suoi insegnamenti decisamente non settari e mistici. Quei religiosi ebbero paura di subire le stesse conseguenze descritte da Zemey nel suo testo, al punto da rinunciare a una cerimonia tenuta dal loro leader spirituale e politico. Minacce esplicite furono fatte pervenire al Dalai Lama anche quando Sua Santità costruì una statua di Padmasambhava nel tempio principale di Dharamsala. La cosa interessante è che le autorità cinesi, come fecero i seguaci di Shugden discepoli del lama Gelupa Pabonka tra il 1920 e il 1940, ancora oggi distruggono in Tibet le statue di Padmasambhava e non altre immagini di Buddha o Bodhisattva. Sarebbe lungo qui spiegarne tutte le ragioni, e forse non basta nemmeno leggere il Libro giallo o il mio testo per comprenderle tutte. Ma di certo è un aspetto molto delicato e importante verso il quale cresce e crescerà in futuro l’interesse di tibetologi e appassionati della cultura tibetana.
8) Lobsang Gyatso, il lama assassinato nel 1997, aveva ingaggiato una vera e propria sfida dialettica con i fondamentalisti…
Raimondo Bultrini. Il direttore della Scuola di dialettica scriveva e parlava francamente di ciò che pensava. E non era contrario al culto solo perché lo diceva il Dalai Lama. Molti Gelupa come lui, anche quando Sua Santità praticava Shugden, erano istintivamente diffidenti verso questo genere di devozione che rasentava il fanatismo. Ho già accennato alle statue distrutte, ma ci sono numerosi episodi nella storia del Tibet che dimostrano le divisioni create sulla base della devozione esagerata verso un “Protettore” esclusivo della scuola Gelupa come Shugden.
9) Cosa ti ha spinto a dedicare quasi dieci anni a indagare e studiare intensamente, con meritoria costanza, nonostante la frenetica e per certi aspetti dispersiva attività giornalistica che conduci, una questione così intricata, oltre che intrigante?
Raimondo Bultrini. A parte le motivazioni giornalistiche (dovetti seguire il caso per scrivere un articolo su La Repubblica) volevo cercare di capire come mai il Dalai lama, che ne era stato un praticante, aveva deciso di eliminare questo culto dalle sue pratiche, sconsigliandolo a tutti i suoi discepoli. Inoltre avevo una specie di istinto che mi diceva: i tre delitti sono solo l’inizio, succederà qualcos’altro (ovvero, com’è realmente accaduto, manifestazioni di dissenso, violenze, cortei anti Dalai lama nel mondo). Il Dalai lama e Namkhai Norbu mi confermarono che dietro al caso Shugden si celava un universo molto più complesso e articolato, e in qualche modo lasciarono che fossi io da solo a scoprirlo, limitandosi a confermare la gravità delle divisioni che questo culto aveva creato nella società tibetana dentro e fuori il Paese. Devo dire che il finale del libro è emerso davvero al termine del mio lavoro. Ho scoperto con mia stessa sorpresa mettendo insieme i vari tasselli del grande puzzle quale complesso meccanismo di relazioni si è instaurato nel tempo tra autorità cinesi e seguaci del gyalpo. Il finale disvela una verità molto più drammatica delle divisioni politiche tra autonomisti e indipendentisti per le sorti del Tibet e della sua straordinaria, in gran parte sconosciuta e potenzialmente utilissima cultura. Se la sua essenza sopravvivrà oltre questi conflitti settari, sono certo che sapremmo apprezzarla meglio col tempo, magari quando ci saremo liberati dagli schemi politico-religiosi che hanno caratterizzato la diffusione del buddhismo tantrico e, va da sé, senza l’infantile e un po’ melensa zavorra dei miti di Shangrilà e Shambala.
10) Hai provato, almeno all’inizio, timore, sgomento, un minimo di paura nell’affrontare un argomento così spinoso?
Raimondo Bultrini. Sì, ho avuto paura. E come nelle storie del Libro giallo, mi sono spesso domandato se certe vicende negative della mia vita fossero conseguenza del mio interesse per questo argomento considerato tabù anche da persone che stimavo altamente. Ma superare la paura, e sopra tutte la paura della morte, è uno dei passaggi necessari per apprezzare il significato degli insegnamenti tibetani. Non si tratta solo di capire la legge del karma, della causa e dell’effetto delle azioni, ma anche il metodo tantrico di superamento delle barriere che possono formare col tempo le tante gabbie in grado di avvolgere la nostra mente. La nostra vita è spesso come quella del prigioniero che rompe il muro della sua cella solo per ritrovarsi in un’altra, e poi un’altra ancora.
11) Nel tuo libro riesci a tratteggiare molto efficacemente una personalità travagliata, introversa, come quella di Dragpa Gyaltsen. Ce ne parli?
Raimondo Bultrini. Dragpa Gyaltsen era figlio di una famiglia tibetana dell’aristocrazia terriera con grandi possedimenti a non molta distanza dalla capitale Lhasa. Secondo l’autobiografia del suo grande contemporaneo, il V Dalai lama Lobsang Gyatso, fu la madre a cercare di promuovere Dragpa Gyaltsen come tulku, candidandolo inizialmente al posto di Dalai lama, salvo poi accettare il suo riconoscimento come erede di un altro tulku – reincarnato – che era stato capo della scuola Gelupa. I due bambini crebbero praticamente insieme nel grande monastero di Drepung dove risiedevano 7.000 monaci e due soli tulku, Dragpa e Lobsang. Fino alla sua misteriosa morte, Dragpa Gyaltsen visse in una dimora chiamata Residenza superiore, quasi a intendere che fosse più elevata non solo fisicamente della stessa Residenza del Dalai Lama, definita “inferiore”. Ma quando Lobsang Gyatso diventerà il Grande V – al quale l’imperatore mongolo Gushri Khan conferirà nel 1642 il massimo potere temporale e spirituale sul Tibet unificato di U e Tsang – la differenza tra i due tulku fu definitivamente evidente. Poco sappiamo di ciò che accadde tra loro, se non dagli accenni nell’autobiografia del V e dalle note riferite ai giorni nostri dal già citato Trijang Rinpoche, ex tutore dell’attuale Dalai lama (Trijang ha sostenuto che Dragpa fu ucciso con una sciarpa rituale dal Reggente del Dalai lama per evitare l’accrescersi della sua popolarità).
Ciò che sappiamo è che Dragpa Gyaltsen venne progressivamente declassato man mano che cresceva il potere del suo quasi coetaneo, e che un sentimento di gelosia e invidia potrebbe aver preso lentamente possesso della mente di questo lama. C’è anche una tesi sostenuta da Trijang e dai suoi seguaci secondo la quale Dragpa Gyaltsen godeva di maggiore credito del Dalai Lama stesso tra i religiosi gelupa e tra molte tribù mongole perché rispecchiava meglio il punto di vista dell’ortodossia della scuola dei Cappelli gialli, mentre il Grande V praticava indistintamente anche altri insegnamenti e specialmente lo Dzogchen. Sappiamo solo – dai resoconti della sua morte – che qualcosa di misterioso e magico accadde durante la cremazione, e che il suo spirito – divenuto potente e vendicativo – prese a vagare per gli altipiani prima di diventare quello che molti considerano ancora oggi il feroce “Protettore” esclusivo dei Cappelli gialli: Shugden. A dar credito al Dalai Lama e ad altri, la sua morte avvenne dopo una sorta di “possessione” da parte di uno spirito demoniaco, e il Grande V dice esplicitamente che ciò avvenne perché Dragpa aveva rotto il “samaya”, la promessa di collaborazione spirituale reciproca tra maestro e discepolo, particolarmente sacra nel buddhismo tibetano. Ho cercato di chiarire questo punto più volte con l’attuale Dalai Lama, e ogni volta Sua Santità ha ripetuto che la “rottura” della promessa o del voto religioso significa l’infrangersi di un patto comune per la realizzazione spirituale reciproca e degli esseri in contatto con noi. In sostanza, Dragpa Gyaltsen non avrebbe agito da buddhista. Sembra un po’ lo stesso tipo di accusa rivolta da Sua Santità ai seguaci di Shugden, ovvero di non agire secondo la dottrina del Buddha ma di seguire un culto spiritista, per di più destinato ad accrescere i poteri mondani dei suoi seguaci, a discapito di quelli spirituali.
12) Torniamo ai nostri giorni. In un’intervista che ti ha rilasciato tre anni fa, il Dalai Lama ha affermato: “Neanche noi tibetani possiamo attribuire tutta la nostra attuale condizione di sofferenza ai cinesi. Guardare ai propri errori è l’inizio del processo di comprensione universale”. Oltre alle riforme mancate, alludeva alla corruzione di alcuni dignitari tibetani resisi ben disposti a favorire le mire cinesi e alla copertura offerta dal culto di Dorje Shugden?
Raimondo Bultrini. Alludeva certamente alle ingiustizie e agli errori commessi sotto varie forme nel corso della storia tibetana. Anche nelle interviste contenute nel libro il Dalai Lama parla di dignitari e membri del clero che hanno di fatto favorito la divisione tra i tibetani aprendo (o quantomeno allargando) la strada all’ingresso dei cinesi.
13) Alcuni lama, intanto, si sono vergognosamente prestati ad accettare come autentico il Panchen Lama imposto da Pechino dopo che quello riconosciuto e accertato direttamente dal Dalai Lama è stato rapito e fatto letteralmente sparire, con tutta la sua famiglia, nel 1989. I giochi si fanno sempre più sporchi.
Raimondo Bultrini. La politica è in generale “sporca”, e i lama devoti al culto sembrano confermare nei fatti di avere a cuore più la politica e – come dice Sua Santità – il beneficio materiale che non quello spirituale. Per beneficio spirituale intendo anche quello che deriva dall’unità di un popolo devoto al dharma e alla messa in pratica della vera compassione buddhista.
14) Una storia come quella da te narrata non può non averti in qualche modo segnato. Cosa ha lasciato in te questo libro?
Raimondo Bultrini. Undici anni di studi, pause, riflessioni, paure, frustrazioni, pensieri di una invalicabile limitatezza intellettuale hanno accompagnato una delicata fase della mia vita rendendola particolarmente tormentata e a tratti cupa. Ma aver potuto valicare la cima di questa enorme montagna ripida e labirintica mi ha dato nuova fiducia, a prescindere dalla compiutezza del risultato e del messaggio che ho cercato di far emergere attraverso il libro, un messaggio rispettosamente dedicato all’essenza degli insegnamenti dei miei maestri. Non vuol dire che ora sono più ottimista, anzi, forse lo sono meno nel breve periodo: stiamo attraversando da tempo con consapevole ignoranza una delle fasi più tremende della storia umana e non siamo certo alla fine dell’incubo. Credo però di sapere adesso che ogni uomo ha la possibilità e potenzialità di guidare il cambiamento, sia personale che collettivo. E’ un po’ come il motto di Obama, Yes, we can. Con la differenza che sul piano spirituale non potremo mai dire che il fine giustifica i mezzi, perché i mezzi sono il fine, e lo strumento della compassione, l’azione della compassione, hanno come principale risultato lo sviluppo della compassione. Il mezzo è il patire insieme le avversità ognuno con la propria abilità e capacità di sopportazione e saggezza, il fine è la scoperta del metodo di liberazione comune per tutti gli esseri. Come marinai colpiti nell’Oceano da una burrasca, saremo costretti un giorno a raddrizzare la nave con tutte le nostre forze, collaborando con mozzi, velisti, capitani e ufficiali, ci siano simpatici o meno.
15) Anche nel suo ultimo intervento al parlamento europeo il Dalai Lama, premio Nobel per la pace nel 1989, ha perorato la causa dell’autonomia tibetana. Per la Cina, però, lui, sempre e soltanto lui, resta d’intralcio al raggiungimento dell’obiettivo della definitiva cancellazione del Tibet.
Raimondo Bultrini. La Cina non cerca la cancellazione del Tibet, ma la sua sottomissione alle regole del sistema materialista, il modello imposto da Pechino: coloni cinesi e tibetani fedeli al Partito che governano il Paese delle nevi sfruttando al massimo le risorse, riducendo i monasteri e i templi a luoghi turistici e le lezioni di religione a corsi di marxismo capitalista. Una popolazione devota solo alla disciplina di regime e ai soldi renderà la competizione tra cittadini un ottimo strumento per accrescere le entrate attraverso una squallida gara di servilismo. Una popolazione devota al dharma rifiuterà invece l’esclusiva competizione materiale basando le proprie aspettative su quello che il re del Bhutan ha chiamato il Tasso interno lordo di felicità, contrapposto al Prodotto interno lordo. FONTE http://www.lacittadella-web.com/forum/viewtopic.php?f=15&t=865&start=10#p3558
Il XIV Dalai Lama e l’affaire Shugden: tra storia, politica e religione
Il 14 e 15 giugno 2014 i media italiani hanno riportato con una certa enfasi la notizia della presenza del XIV Dalai Lama a Livorno. Ovviamente non si sono soffermati sui contenuti degli insegnamenti buddhisti impartiti in quei giorni ad alcune migliaia di persone giunte da tutta Europa, bensì su due fatti: la consegna a Sua Santità della cittadinanza onoraria da parte del Sindaco appena eletto nelle liste del movimento politico guidato da un comico genovese, e soprattutto la manifestazione contro il Dalai Lama inscenata da circa 400 persone appartenenti alla Comunità Internazionale Shugden (ISC), presunta vittima di persecuzioni religiose e di violazioni dei diritti umani da parte del Premio Nobel per la Pace e dei suoi seguaci. Per molte ore infatti gli insegnamenti sono stati accompagnati dall’eco dello slogan ripetuto come un mantra all’esterno del Pala Modigliani: “Stop Dalai Lama, Stop Lying! Stop Dalai Lama, Stop Lying!”.
Il 4 febbraio 1997 a Dharamsala, nell’India del Nord, a pochi passi dalla residenza del Dalai Lama in esilio, Geshe Lobsang Gyatso, direttore della Scuola di Studi Dialettici Buddhisti e due monaci suoi collaboratori sono stati uccisi a coltellate mentre lavoravano sulla storia del Quinto Dalai Lama. La polizia indiana identificò i presunti responsabili in alcuni seguaci del culto di Shugden poi fuggiti in Tibet (e tuttora in libertà…).
Ancor prima, nel 1986, proprio a Dharamsala, il Dalai Lama aveva pubblicamente dichiarato: “Ultimamente vi sono stati problemi connessi con il protettore Gyalchen Shugden. Quanti di voi vivono in India lo sanno bene e non devo ripeterli. Ma quei tibetani che lo accettano solo sulla base della sua reputazione di grande protettore dei Gelugpa non fanno del bene al Tibet, né religiosamente né politicamente”.
Ma… chi o che cosa è Shugden? Poiché tale voce curiosamente non sembra comparire nel meritorio Dizionario del Buddhismo di Philippe Cornu, si può leggere ciò che dice Donald Lopez, docente di studi buddhisti negli Usa, secondo cui Dorje Shugden (Rdo rje Shugs Ldan, Fulmine Poderoso, o Portatore della Forza del Vajra) “è un’importante divinità protettrice della scuola Gelug, ma di origini recenti”.
Nel complesso pantheon del Buddhismo del Tibet, il Vajrayana (Veicolo Adamantino), i Protettori del Dharma, in sanscrito Dharmapala, sono deità che hanno il compito di custodire gli insegnamenti e proteggere i praticanti. Nonostante siano spesso raffigurati con un aspetto irato, terrifico, non sono dei demoni malvagi, anzi vengono invocati per dissipare gli ostacoli sulla via spirituale.
Tradizionalmente vengono riconosciuti due tipi di Dharmapala:
– i protettori di saggezza, emanazioni dei buddha e dei bodhisattva, e
– i protettori mondani: “spesso si tratta di deità locali molto antiche, di demoni o spiriti potenti che, dopo essere stati soggiogati [dai grandi maestri buddhisti] hanno offerto loro la propria essenza vitale” e hanno giurato di preservare gli insegnamenti. Molti di essi appartengono alle religioni tibetane pre-buddhiste (genericamente definite Bön). Alcuni sono specificamente legati a taluni luoghi del Tibet, a singole scuole buddhiste e a particolari monasteri. Ad esempio Pehar, che è molto importante per i Gelugpa e per i Nyingmapa, ed è il protettore ufficiale del governo tibetano, il quale lo consulta attraverso l’oracolo-medium di Nechung.
Shugden, originario del Tibet Occidentale, appartiene alla classe dei protettori mondani, anche se i praticanti del suo culto lo ritengono una emanazione di Manjusri (“Dolce Gloria”), ilbodhisattva personificazione del principio della Saggezza dei buddha.
Lopez ha definito Shugden “di origini recenti”: l’espressione è vera se la si intende in relazione alla storia del Buddhismo in Tibet, che inizia nel VII secolo d.C.
Il mito di Shugden nasce invece molto più tardi, nel XVII secolo, all’epoca del Dalai Lama Lobsang Gyatso, il “grande Quinto” (1617-1682), nella cui persona si attuò una piena convergenza di potere spirituale e potere temporale. Come tutti i Dalai Lama, apparteneva alla scuolaGelugpa, ma si aprì anche agli insegnamenti dei Nyingmapa, la scuola “degli Antichi”, fondata da Padmasambhava (“Nato dal Loto”) nell’VIII secolo dopo che ebbe soggiogato le forze occulte che ostacolavano la diffusione del Buddhismo nel Tibet. Le aperture del Grande Quinto suscitarono le ire di molti monaci Gelug, che consideravano Padmasambhava un eretico.
Quando Lobsang venne incoronato Dalai Lama, nel 1642, tra i settemila monaci del monastero di Drepung dove viveva c’erano solo due tulku, ufficialmente riconosciuti come rinascite di grandi maestri del passato: uno era lo stesso Lobsang, l’altro era Dragpa Gyaltsen, un dotto monaco di origini aristocratiche, anch’egli candidato alla carica di Dalai Lama. Venne scelto Lobsang, e Dragpa fu invece riconosciuto come successore di Panchen Sonam Dragpa, un grande studioso e maestro del terzo Dalai Lama, vissuto nella seconda metà del 1500. La cosa non fu accettata da tutti e una profonda rivalità si instaurò tra i seguaci di Lobsang e quelli di Dragpa, i quali lo consideravano il solo rimasto a difendere la pura tradizione Gelugpa.
Nel 1656, a soli 38 anni, Dragpa morì, forse suicidandosi ritualmente ingoiando una sciarpa cerimoniale, forse assassinato con la sciarpa stessa per aver sfidato il Dalai Lama ad un dibattito filosofico, o forse per malattia.
Secondo l’autobiografia del Grande Quinto, che si recò per pregare presso Dragpa, già gravemente malato, “il tulku era come impossessato da un demone e la sua mente non era chiara, perciò la pratica non ebbe effetto e il tredicesimo giorno del mese [di luglio] morì”.
Durante la cerimonia di cremazione avvennero però fatti stupefacenti, che 300 anni dopo saranno così narrati da Trijang Rinpoche, secondo tutore dell’attuale Dalai Lama e devoto di Shugden: “Applicato il fuoco alla pira, cominciò il rito. Il fumo si eresse come una colonna, dritto, bianco, e tre parti distinte volarono via nel cielo. L’attendente di Dragpa Gyaltsen, quando vide alzarsi quelle nuvole dalla forma pacifica supplicò il maestro: “Motivati da gelosia e intenzioni cattive ti hanno ucciso, e tu ancora mostri un aspetto gentile”. Allora con lo scialle da monaco sventolò l’aria e il fumo si divise. Due parti si diradarono nel cielo, una parte divenne scura e prese la forma di un pugno chiuso, si abbassò verso terra con un movimento a spirale muovendosi nella direzione di Tsangpu passando da Dembag (uno spiazzo sotto al monastero), segno che l’aspetto della saggezza della mente di Dragpa Gyaltsen andò a chiedere l’aiuto di Setrap [uno spirito guardiano locale].
Nel fuoco, il corpo di Dragpa Gyaltsen non bruciò e fu costruito uno stupa d’argento a base ottagonale per contenerlo, poi lo stupa fu trasportato provvisoriamente nella Residenza Superiore. I custodi sentirono esplosioni, voci, lamenti e suoni spaventosi provenire dall’interno, così che nessuno poteva nemmeno transitare lì vicino. Interpellato l’oracolo di Nechung, il Reggente fece aprire lo stupa d’argento, estrasse il corpo, lo mise in una scatola di legno e lo fece gettare nel fiume Kyichu”, dove la corrente lo trascinò via.
Nei giorni successivi il Dalai Lama ebbe incubi e visioni negative, molti monaci si ammalarono, alcuni morirono. Tutti questi segni furono attribuiti allo spirito di Dragpa, “sorto nell’aspetto di una divinità violenta”, come dice Trijang Rinpoche.
Si trattava di Shugden, chiamato anche Dholgyal o Gyalchen, “uno spirito perfido molto potente scaturito da chi ha deliberatamente mancato di mantenere la parola o promessa al suo lama a causa di risentimento o dissenso ed è nato da preghiere distorte, così da danneggiare l’insegnamento del Buddha e gli esseri senzienti”. Sono le parole del Grande Quinto, il quale divenne il bersaglio di Shugden e si ammalò. Si verificarono altre morti di monaci, carestie, terremoti, fino a che venne deciso di procedere al Rito del Fuoco, un potente esorcismo per distruggere lo spirito. Secondo quanto narrato nella biografia di un lama che partecipò alla puja, “i Messaggeri Operatori del Rito [presero] l’incontrollabile spirito elementare che vagava di notte, lo legarono alla vita, lo uccisero e lo mangiarono. Tutti i partecipanti udirono grida e avvertirono odore di bruciato”. Pare invece che in sostanza l’esorcismo non funzionò: il Dalai Lama guarì completamente, ma la sua stessa biografia afferma che lo spirito si allontanò e si recò presso il monastero Sakyapa, dove un maestro gli diede un rifugio e dove gli venne poi costruita una cappella.
Da lì cominciò la vicenda di Dholgyal/Shugden, che segnò i secoli successivi della storia del Tibet e, dopo l’invasione cinese, dei Tibetani in esilio. Il culto a lui dedicato si diffuse rapidamente, i riti venivano praticati in diversi monasteri, il che era anche favorito dai gravi problemi che il paese doveva affrontare: dopo la scomparsa del Grande Quinto e le tortuose vicende che accompagnarono la vita del sesto , cinque Dalai Lama, dall’ottavo al dodicesimo, morirono da bambini o vennero comunque uccisi; i Cinesi approfittarono della situazione e intorno al 1720 inviarono soldati in Tibet per proteggerlo dai Mongoli. Questo fatto ancora oggi è usato dal governo cinese per legittimare le proprie pretese su quei territori strategicamente molto importanti. Da allora la figura di Shugden iniziò ad intrecciarsi indissolubilmente con la storia dei rapporti politici tra Cina e Tibet.
Molti lama della scuola Gelug ed esponenti del governo tibetano presero a rivolgersi allo spirito, chiedendogli di diventare un protettore della loro scuola dalle influenze dei Nyingmapa, e Shugden acconsentì, fino a diventare uno dei principali protettori dei Gelugpa. Sua funzione specifica era quella di impedire ogni tipo di mescolanza tra le due scuole, al punto che a un Gelugpa era fatto divieto perfino di toccare i testi Nyingma.
Il riconoscimento “ufficiale” di tale ruolo avvenne nel 1837, quando, alla morte del X Dalai Lama, l’ambasciatore cinese si recò nel principale tempio di Shugden per chiederne un parere ed ebbe risposte che ritenne corrette. L’Imperatore concesse allora il riconoscimento dello spirito come Protettore della scuola.
L’immagine di Shugden, la sua dimora e i riti a lui connessi vennero stabiliti con precisione:
“All’interno del palazzo sono gettati qua e là cadaveri umani e carcasse di cavalli, e il sangue degli uomini e dei cavalli si unisce a formare un lago. Pelli umane e pellicce di tigre pendono come tendaggi. Il fumo della ‘grande offerta del fuoco’ [carne umana] si diffonde nelle quattro direzioni del mondo. All’esterno, sulla terrazza, si dimenano cadaveri resuscitati e rakṣasa [demoni], e le quattro classi di scheletri eseguono la loro danza. Da ogni lato pendono tappezzerie fatte di pelle d’elefante e pelle tolta ai cadaveri. Vi sono ‘stendardi della vittoria’ e stendardi circolari fatti con corpi di leone, nappe fatte di visceri colanti, ghirlande di teste, ornamenti ricavati dai cinque organi sensoriali, scacciamosche di capelli umani, e altri oggetti spaventosi…
All’interno… [c’è] lo spaventoso rDo rje shugs ldan [Dorje Shugden], di colore rosso scuro, feroce come un selvaggio rakṣasa, dalla bocca simile all’abisso dello spazio. Scopre quattro zanne, taglienti come lastre di ghiaccio, tra cui arrotola la lingua alla velocità della saetta, facendo tremare i tre mondi… La fronte è contratta per l’ira. I tre occhi iniettati di sangue guardano irati i vighna [ostruttori] nemici. Le fiamme giallo-rosse che escono dai sopraccigli e dai peli della faccia bruciano completamente le quattro classi di bdub [demoni]. I capelli giallo-bruni sono ritti sulla testa, e in cima, al centro, in un mandala solare, risiede il signore protettore e re della religione, il grande Tsong kha pa in aspetto pacifico.
Muovendo rapidamente le orecchie, rDo rje shugs ldan provoca un fortissimo vento che distrugge il male e spazza via i malfattori, gli spergiuri e i demoni creatori di ostacoli. Dalle narici prorompono nuvole cariche di pioggia, da cui escono tuoni e fulmini che percuotono con lampi gialli la terra dei vighna”.
Ogniqualvolta in Tibet si verificavano dei tentativi di creare collegamenti tra scuole diverse – ad esempio nel XIX secolo, col movimento Ris Med (Rimé, “senza restrizioni”, “non settario”), o nei primi decenni del XX, con le prime esperienze di modernizzazione del Paese da parte del XIII Dalai Lama – il culto di Shugden riprendeva vigore, opponendosi ad ogni apertura e rinnovamento.
Un importante esponente del culto fu il monaco Pha bong kha pa (Pabonka), uno dei più grandi maestri tibetani del XX secolo, guru di Trijang, il già citato tutore del XIV Dalai Lama. “Rivolto tanto ai monaci che ai laici, il movimento [guidato da Pabonka] favoriva un forte senso di identità comunitaria in un momento in cui quella stessa identità veniva minacciata dalla spinta modernizzatrice del governo e da influenze esterne”. Poiché il culto era così diffuso ai più alti livelli della scuola Gelug, fino ai tutori dell’attuale Dalai Lama, anche quest’ultimo ne fu profondamente influenzato e per molti anni incluse le preghiere a Shugden nella propria pratica religiosa quotidiana, favorendo la devozione nei confronti del Protettore da parte del clero. L’oracolo di Shugden divenne così il secondo per importanza dopo Nechung.
Si disse anche che fu proprio Shugden, nel 1959, a consigliare il giovane Dalai Lama a fuggire in India prima del definitivo attacco cinese alla sua residenza a Lhasa.
La diaspora dei Tibetani non contribuì affatto a ricomporre le divisioni: anche durante l’esilio, molti continuarono a pensare che i problemi del Tibet fossero dovuti alle eccessive aperture verso le altre scuole e verso il mondo esterno, e che solo Shugden potesse costituire la soluzione.
Ma a partire dagli anni ’70 si verificò un profondo cambiamento: il Dalai Lama ebbe diversi sogni e premonizioni intorno al culto di Shugden, ne studiò a fondo la storia e la dottrina e nel 1975 pervenne alla decisione di abbandonare la pratica, scoraggiando chiunque a seguirla. Affermò che Shugden non era “né un buddha né l’incarnazione di Drakpa Gyaltsen, ma una divinità mondana, forse uno spirito nefasto, il cui culto alimentava il settarismo nella comunità in esilio, ostacolando la causa dell’indipendenza tibetana”. In una intervista recente, ha ribadito un elemento fondamentale nel Buddhismo, ovvero l’aver personalmente sperimentato gli effetti di una pratica: “Se ho deciso di sconsigliarne il culto [di Shugden] è perché ho sperimentato a mia volta i problemi che possono sorgere affidandosi a questi esseri e ho avuto numerose esperienze durante i sogni e le divinazioni [..]. Se prendi come vero rifugio l’Oracolo o una divinità che non sia trascendente, oltre i limiti dell’attaccamento, il tuo legame con i Tre Gioielli, il Buddha, i suoi insegnamenti e la comunità religiosa, è perso”.
Già nel 1973 Zemey Rinpoche, discepolo di Trijang, aveva pubblicato un “Libro Giallo”, nel quale raccontava in dettaglio le disgrazie di cui furono vittime i monaci che avevano mescolato le pratiche Gelug con quelle di altre scuole, provocando la reazione di Shugden. Ma il testo venne condannato dal Dalai Lama, il quale “non tornò mai sulle sue decisioni, e fece sapere che se i suoi consigli non fossero stati ascoltati avrebbe negato a coloro che fossero rimasti legati a Dorje Shugden la possibilità di presenziare ai suoi insegnamenti”: nel 1996, durante le celebrazioni del Capodanno tibetano (Losar) in India, chiese a tutti i devoti di Shugden di abbandonare la cerimonia, a causa del legame karmico che si instaura durante le iniziazioni tra il lama e l’iniziato. In caso contrario la sua stessa salute ne sarebbe stata danneggiata.
La decisione del Dalai Lama provocò naturalmente gravi lacerazioni nelle gerarchie e nella comunità Gelugpa. Ne nacque una controversia che non solo non è terminata, ma che si è progressivamente inasprita. “Alcuni si spinsero al punto di dichiarare che il Dalai Lama non era il vero Dalai Lama, e che quarant’anni prima era stato scelto il bambino sbagliato”. I devoti di Shugden, guidati da Geshe Kelsang Gyatso, un monaco trasferitosi in Inghilterra (la setta è presente e molto attiva anche in Occidente), accusarono Sua Santità di violare la libertà religiosa, di essere intollerante, di provocare la persecuzione dei devoti di Shugden nei monasteri e nei villaggi.
Infine, come si è detto, nel 1997 dalle violenze verbali si passò a quelle fisiche, quando Geshe Lobsang Gyatso, acceso oppositore del culto di Dorje Shugden, fu ucciso a Dharamsala con due discepoli, e la setta fu sospettata dell’omicidio. Ciononostante, i seguaci di Shugden continuano a presentarsi nel ruolo delle vittime di una vera e propria persecuzione, che “avrebbe fatto perdere il lavoro a molti tibetani in India e fatto espellere molti monaci dai monasteri”. Un atteggiamento vittimistico, è da dire, piuttosto tipico nelle organizzazioni con caratteristiche settarie.
Da parte sua, la Cina, che nella sua storia è sempre stata molto attenta a quanto avviene sul Tetto del Mondo, non ha perso le ghiotte occasioni di intervento che l’affaire Shugden le ha offerto, ben consapevole che l’invasione del 1950 e del 1959 e le successive violente repressioni di ogni richiesta di autonomia e di ogni forma di dissenso hanno tutt’altro che risolto il problema Tibet. Dopo aver fatto nominare Panchen Lama, la seconda autorità spirituale tibetana dopo il Dalai Lama, una persona gradita al Partito, ha sponsorizzato la causa dei devoti di Shugden: “oggi le nuove generazioni di tulku, lama, geshe e monaci viventi nella Regione Autonoma del Tibet ricevono un’educazione sempre più regolarmente improntata sulla tradizione di Dorje Shugden”, e “nella Repubblica Popolare sono stati approvati stanziamenti extra destinati alla costruzione di nuovi templi [a lui] dedicati, all’estero sono state finanziate le attività di proselitismo per promuover[ne] il culto”. Dal loro canto, i seguaci del Protettore creano consenso verso il regime cinese e cercano di screditare la figura del Dalai Lama agli occhi dei Tibetani – nel Tibet occupato e in esilio – e di fronte all’opinione pubblica internazionale. Non si può dire quanto questo sia il frutto di scelte consapevoli o meno, ma resta il fatto che “il culto di Shugden è oggi l’arma con cui Pechino cerca di dividere la comunità tibetana”, per giungere infine ad eliminare ogni traccia del lignaggio dei Dalai Lama, oppure a scegliere un Dalai Lama “fantoccio” del regime comunista.
L’affaire Shugden ad oggi è lontano dall’essere chiuso, il culto è ben presente nella comunità tibetana e si è radicato anche tra i praticanti occidentali del Buddhismo Vajrayana. Le proteste pubbliche contro la persona del Dalai Lama da parte dei seguaci di Shugden non sono affatto cessate, come pure le prese di posizione a favore delle sue decisioni. La vicenda continuerà ad affiancare e a segnare la storia attuale del popolo tibetano e della sua cultura, il cui esito è ancora tutto da scrivere.
DA LEGGERE
Per chi volesse approfondire i temi legati alla vicenda Shugden, è imprescindibile un ottimo volume del 2008: Il demone e il Dalai Lama – Tra Tibet e Cina, mistica di un triplice delitto, pubblicato da Baldini Castoldi Dalai Editore.
L’autore, Raimondo Bultrini, è un documentarista e giornalista specializzato sull’Asia e sul Buddhismo, collaboratore del gruppo La Repubblica/L’Espresso. Nel suo libro ha ripercorso la storia del Protettore Shugden partendo dal triplice omicidio di Dharamsala e, mescolando abilmente stile narrativo e taglio giornalistico, interviste e saggistica storica, ha ricostruito in maniera documentata e di piacevole lettura l’intricata storia che abbiamo cercato di riassumere. La quale non è, come si potrebbe erroneamente ritenere, una curiosa vicenda del tutto interna al mondo tibetano e/o buddhista. In realtà, come Bultrini stesso osserva, “le implicazioni del caso Shugden meritano di essere approfondite proprio perché rappresentano un esempio della direzione verso la quale possono portare le relazioni tra il futuro grande potere planetario, la Cina, il Tibet e il resto del mondo”.
CONSIDERAZIONI MARGINALI
Sorge a questo punto una domanda, che apre un campo di ricerca tutto da esplorare: la vicenda Shugden, soprattutto nelle modalità con cui si è manifestata nei tempi recenti, può definirsi come un caso di “fondamentalismo buddhista”?
Ha scritto F. Maroaldi su La Repubblica: “Il fondamentalismo islamico rappresenta da anni il principale pericolo della convivenza planetaria. Del fondamentalismo induista si sente parlare sempre più spesso [..]. Neppure ebraismo e cristianesimo possono dichiararsi indenni da febbri integraliste [..]. Fin qui, l’unica religione che pareva non correre tale rischio era il buddhismo”, ma il culto di Shugden sembra smontare tale immagine stereotipata e falsamente idilliaca di una tradizione plurimillenaria.
Ferma restando la necessità di pervenire ad una esatta definizione di concetti qualifondamentalismo ed integralismo, che non sono del tutto sinonimi, e tenuto altresì conto del fatto che il fondamentalismo non è un fenomeno solo religioso, ma coinvolge innumerevoli aspetti della vita umana, chi scrive ritiene che molti eventi della storia più o meno recente del Buddhismo debbano essere attentamente studiati non solo dagli specialisti, ma anche dai praticanti, soprattutto occidentali, che spesso tendono ad ignorarli o a considerarli estranei, ininfluenti rispetto alla pratica personale e collettiva. Come se fossero sufficienti la distanza temporale o geografica, o la redazione di una lettera di “scuse” da parte di qualche istituzione religiosa per considerare chiusa la questione.
Solo a titolo di esempio, oltre all’affaire Shugden, si possono menzionare il consenso e il supporto fornito all’imperialismo giapponese nel XX secolo da parte di moltissimi monasteri Zen; la politica persecutoria del governo cingalese appoggiato dalla maggioranza buddhista contro le minoranze induiste, musulmane e cristiane; la disputa tra il governo thai e quello cambogiano per il possesso di un tempio khmer; la persecuzione dei musulmani in Myanmar ecc.
Esempi da studiare, come fece con Shugden il Dalai Lama, che non ha poi esitato ad abbandonare una pratica secolare. E da approfondire bene, sotto tutti i punti di vista, storico, politico, culturale, ricercandone le cause nella storia dei popoli e delle istituzioni civili e religiose, nelle strutture sociali ed economiche, nelle stesse tradizioni ed insegnamenti del Buddhismo, dei buddhismi.
Almeno sotto un certo aspetto, una risposta provvisoria è già possibile: sì, un fondamentalismo buddhista non solo è possibile, ma esiste, e va ricercato in sé stessi, in quanto, ancor prima di un fatto storico, esso è un modo di essere della mente, che si manifesta nell’ignoranza, intesa nel suo significato comune, come assenza di studio intellettuale; nella mancanza di spirito critico; nell’illusione di poter delegare ad altri il proprio cammino evolutivo; nella paura delle “contaminazioni”; nel desiderio di appartenenza, di ortodossia/ortoprassi, di adesione ad un modello “autentico” (il vero-buddhismo, il vero-zen, il vero-maestro, il vero-*).
La scuola Gelugpa, detta anche dei “Berretti Gialli”, fu fondata nel XIV secolo dal lama riformatore Tsong Khapa. A partire dal XVII secolo si diffuse in tutto il Tibet.
Pabonka (Ciampa Tenzin Trinley Gyatso, 1878-1941 o 1943) fu il principale maestro dei due tutori dell’attuale Dalai Lama. Fu autore de La Liberazione nel Palmo della Tua Mano, un testo fondamentale della tradizione Lam Rim (Stadi del Sentiero), iniziata col maestro Atisha (982-1054) e proseguita con Lama Tsong Khapa. È pubblicato in italiano presso le Edizioni Chiara Luce.
C. Astarita, Come si diventa un’ex divinità, in: http://www.rivistastudio.com/standard/come-si-diventa-unex-divinita/
Si veda la “Dichiarazione” sottoscritta da moltissimi centri di pratica italiani in:http://www.taracittamani.it/dichiarazione-il-culto-di-dogyalshugden/
F. Maroaldi, Il demone del Dalai Lama, su: La Repubblica dell’8.10.2008.
http://zenvadoligure.blogspot.it/2016/02/il-xiv-dalai-lama-e-laffaire-shugden_12.html