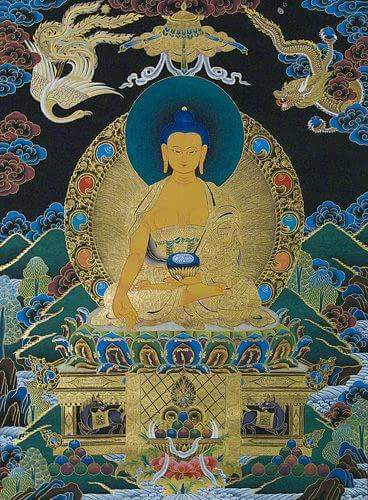
Il Buddha: “Questo non è mio, questo non sono io, questo non è il mio sé”.
Pema Jigdrel: Il dogma del non sé
La cultura buddhista è dominata da dogmi basati su fraintendimenti o interpretazioni errate. Uno di questi dogmi, forse il più rilevante, è quello del “non sé”: in pāli anattā, in sanscrito anātmā. (Entrambi i termini sono maschili e declinati al nominativo. Le forme non declinate sono anattan e anātman.)
Il dogma del “non sé” purtroppo deriva da un’interpretazione errata del termine originario così come è impiegato nei sutta, i discorsi in lingua pāli attribuiti al Buddha. La fonte più significativa è Il discorso sulla caratteristica del non sé (Anatta-lakkhaṇa-sutta), (Saṁyutta Nikāya 22.59. Vedi Piya Tan, SD 1.2. Testo pāli: suttacentral.net.) qui tradotto. Si ritiene che il Buddha abbia avuto tale dialogo con i primi cinque discepoli. In ogni caso, l’argomentazione centrale è la stessa di un dialogo posteriore (Saṁyutta Nikāya 22.88. Vedi Piya Tan, SD 42.8.) e il tema del “non sé” è trattato con espressioni simili anche in altri sutta (Cfr. Majjihima Nikāya 35 (Piya Tan, SD 26.5, pp. 70-74); Majjihima Nikāya 109 (Piya Tan, SD 17.11); Majjihima Nikāya 148 (Piya Tan, SD 26.6, pp. 85-92); Saṁyutta Nikāya 22.76; Piya Tan, SD 26.7).
La prima frase in cui compare anattā recita così: «La forma, o monaci, è non sé» Rūpaṁ bhikkave anattā. La “forma” (rūpa) è il primo dei cinque aggregati della propria esperienza psicofisica: il corpo con le facoltà sensoriali e i relativi oggetti percepiti. La medesima formula ricorre anche in riferimento agli altri aggregati. «La sensazione è non sé». «Il concetto è non sé». «Gli impulsi sono non sé». «La percezione è non sé».
La sensazione può essere piacevole, neutra o sgradevole. Il concetto è la nozione o idea dell’oggetto percepito. Gli impulsi sono le spinte interiori a compiere determinate azioni. La percezione è la ricezione cosciente dei dati sensoriali e mentali.
Il Buddha insegnava che i cinque aggregati sono non sé, ma tanto il termine pāli anattā quanto il corrispondente sanscrito anātmā sono stati interpretati diversamente, dando origine a distinte correnti spirituali e tradizioni filosofiche. Attualmente il dibattito sull’interpretazione non sembra interessare i buddhisti occidentali e anche in Oriente pare che abbia prevalso un punto di vista: anattā oppure anātmā indicherebbe la negazione di qualsiasi sé/io.
Siccome si crede che il Buddha abbia negato l’esistenza reale del sé/io, in contrapposizione a chi la sosteneva sulla base dell’autorità dei Veda, si ritiene che l’illuminazione da lui conseguita coincida con la cessazione o dissoluzione del sé/io. Di conseguenza, non solo molti ricercatori spirituali trascorrono la vita aspirando a tale realizzazione, ma alcuni arrivano anche a sperimentare stati di coscienza in cui sembra che il sé/io sia effettivamente svanito. Perciò è comprensibile che l’esperienza mistica del non sé sia stata collegata al disturbo dissociativo della “depersonalizzazione” (George Deane, Mark Miller and Sam Wilkinson, “Losing Ourselves: Active Inference, Depersonalization, and Meditation”, Frontiers in Psychology, October 2020, Vol. 11:539726, pp. 1- 15 frontiersin.org).
Eppure, è sufficiente studiare senza preconcetti la prima fonte buddhista che attesta la nozione di anattā per capire che sia l’esperienza mistica della dissoluzione del sé/io sia il disturbo della depersonalizzazione non hanno alcuna connessione con l’insegnamento originario del Buddha.
Ciò che è negato dal prefisso an, “non”, è attā/ātmā, ossia “sé”, che può essere inteso come pronome riflessivo o nome. L’attuale interpreazione prevalente intende “sé” come nome che indica non solo l’io, ma anche la nozione di una sostanza psichica eterna, una sorta di anima immortale. Se così fosse, le frasi del sutta precedentemente tradotte affermerebbero che i cinque aggregati sono senza sé, privi di un io o un’anima eterna. In questo caso anattā sarebbe un aggettivo, che dovrebbe concordare nel genere e nel numero col nome a cui si riferisce, ma i conti non tornano: anattā è invariabilmente maschile singolare; invece rūpaṁ (forma) è neutro singolare; vedanā (sensazione) è femminile singolare; saññā (concetto) è femminile singolare; saṅkhārā (impulsi) è maschile plurale; e viññāṇaṁ (percezione) è neutro singolare. Conclusione: anattā non è un aggettivo, bensì un nome composto. In questo caso la traduzione “non sé” sarebbe analoga alla locuzione “non io” (Nicht Ich) della filosofia di J.G. Fichte.
Gli aggregati della propria esperienza psicofisica sono anattā, “non sé”, nel senso che non sono davvero sé, ossia non sono realmente l’essere che sperimenta i cinque aggregati personali. Affinché questa verità potesse essere compresa direttamente, il Buddha aveva escogitato alcune strategie dialogiche.
La prima strategia presentata nel sutta qui tradotto consiste nel constatare che gli aggregati portano alla malattia, ossia a qualche disturbo fisico o mentale. Se fossero davvero sé, l’individuo che li possiede avrebbe il pieno controllo su di essi e, quindi, sarebbe capace di impedire l’insorgenza del disturbo o eliminarlo a volontà.
La seconda strategia è il riconoscimento del fatto che i cinque aggregati sono transitori, non permanenti; ma ciò che è transitorio è anche doloroso, perché la precarietà di quello che si ama non è piacevole. Dunque, non è per nulla sensato identificare se stessi, il proprio sé, con ciò che è transitorio, doloroso e soggetto a cambiamenti, pensando: «Questo è mio, questo sono io, questo è il mio sé».
In conclusione, si dovrebbe comprendere profondamente che gli aggregati della propria esperienza psicofisica sono “non sé”, ossia nessuno di essi è realmente sé, il proprio vero sé: «Questo non è mio, questo non sono io, questo non è il mio sé». Il sé reale, il vero io, non è affatto negato, ma è riconosciuto come ciò che è per natura libero dalle impurità del non sé. Quando viene meno l’illusoria identificazione di sé con il non sé, ciò che rimane è «la coscienza priva di attributo, senza fine, tutt’intorno luminosa». (Dīgha Nikāya 11 (Piya Tan, SD 1.7, p. 174). Cfr. Majjhima Nikāya 49 (Piya Tan, SD 11.7, p. 101).
L’effetto del discernimento tra sé e non sé è il disincanto dai cinque aggregati, l’assenza di attrazione per essi. Essendo venuto meno l’incanto dell’attrazione, c’è distacco, mancanza di desiderio; e il distacco rende possibile la liberazione dalle impurità delle afflizioni (ignoranza, brama, odio, ecc.) che legano al saṁsāra. Il riconoscimento dell’avvenuta liberazione comporta la certezza che il processo karmico della rinascita è terminato. Non occorre più seguire un sentiero spirituale per conseguire la liberazione. Tutto ciò che deve essere fatto per liberarsi è stato fatto. Non ci sarà un’altra rinascita.
IL DISCORSO SULLA CARATTERISTICA DEL NON SÉ
Un tempo il Beato soggiornava a Vārāṇasī, nel Parco delle Gazzelle a Isipatana (Sārnāth).
Là, dunque, il Beato convocò i monaci, il gruppo dei cinque (Koṇḍañña, Vappa, Bhaddiya, Mahānāma e Assajī): «Monaci!».
«Venerabile!» risposero i monaci al Beato.
Il Beato disse: «Monaci, la forma è non sé. Monaci, se la forma fosse invero questo, sé, la forma non sarebbe questo: non potrebbe portare alla malattia, e riguardo alla forma sarebbe possibile decidere: “La mia forma sia così. La mia forma non sia così”. Monaci, siccome la forma è non sé, la forma porta alla malattia e non è possibile decidere riguardo alla forma: “La mia forma sia così. La mia forma non sia così”.
«La sensazione è non sé. Monaci, se la sensazione fosse invero questo, sé, la sensazione non sarebbe questo: non potrebbe portare alla malattia, e riguardo alla sensazione sarebbe possibile decidere: “La mia sensazione sia così. La mia sensazione non sia così”. Monaci, siccome la sensazione è non sé, la sensazione porta alla malattia e non è possibile decidere riguardo alla sensazione: “La mia sensazione sia così. La mia sensazione non sia così”.
«Il concetto è non sé. Monaci, se il concetto fosse invero questo, sé, il concetto non sarebbe questo: non potrebbe portare alla malattia, e riguardo al concetto sarebbe possibile decidere: “Il mio concetto sia così. Il mio concetto non sia così”. Monaci, siccome il concetto è non sé, il concetto porta alla malattia e non è possibile decidere riguardo al concetto: “Il mio concetto sia così. Il mio concetto non sia così”.
«Gli impulsi sono non sé. Monaci, se gli impulsi fossero invero questo, sé, gli impulsi non sarebbero questo: non potrebbero portare alla malattia, e riguardo agli impulsi sarebbe possibile decidere: “I miei impulsi siano così. I miei impulsi non siano così”. Monaci, siccome gli impulsi sono non sé, gli impulsi portano alla malattia e non è possibile decidere riguardo agli impulsi: “I miei impulsi siano così. I miei impulsi non siano così”.
«La percezione è non sé. Monaci, se la percezione fosse invero questo, sé, la percezione non sarebbe questo: non potrebbe portare alla malattia, e riguardo alla percezione sarebbe possibile decidere: “La mia percezione sia così. La mia percezione non sia così”. Monaci, siccome la percezione è non sé, la percezione porta alla malattia e non è possibile decidere riguardo alla percezione: “La mia percezione sia così. La mia percezione non sia così”.
«Allora, cosa pensate, monaci: la forma è permanente o transitoria?».
«Transitoria, Venerabile».
«Ciò che è transitorio è doloroso o piacevole?».
«Doloroso, Venerabile».
«Dunque, è corretto considerare così ciò che è transitorio, doloroso, soggetto a cambiamenti: “Questo è mio, questo sono io, questo è il mio sé”?».
«No affatto, Venerabile».
«Allora, cosa pensate, monaci: la sensazione è permanente o transitoria?».
«Transitoria, Venerabile».
«Ciò che è transitorio è doloroso o piacevole?».
«Doloroso, Venerabile».
«Dunque, è corretto considerare così ciò che è transitorio, doloroso, soggetto a cambiamenti: “Questo è mio, questo sono io, questo è il mio sé”?».
«No affatto, Venerabile».
«Allora, cosa pensate, monaci: il concetto è permanente o transitorio?».
«Transitorio, Venerabile».
«Ciò che è transitorio è doloroso o piacevole?». «Doloroso, Venerabile».
«Dunque, è corretto considerare così ciò che è transitorio, doloroso, soggetto a cambiamenti: “Questo è mio, questo sono io, questo è il mio sé”?».
«No affatto, Venerabile».
«Allora, cosa pensate, monaci: gli impulsi sono permanenti o transitori?».
«Transitori, Venerabile».
«Ciò che è transitorio è doloroso o piacevole?».
«Doloroso, Venerabile».
«Dunque, è corretto considerare così ciò che è transitorio, doloroso, soggetto a cambiamenti: “Questo è mio, questo sono io, questo è il mio sé”?».
«No affatto, Venerabile».
«Allora, cosa pensate, monaci: la percezione è permanente o transitoria?».
«Transitoria, Venerabile».
«Ciò che è transitorio è doloroso o piacevole?».
«Doloroso, Venerabile».
«Dunque, è corretto considerare così ciò che è transitorio, doloroso, soggetto a cambiamenti: “Questo è mio, questo sono io, questo è il mio sé”?».
«No affatto, Venerabile».
«Pertanto qui, monaci, qualunque sia la forma, passata, futura, presente, interna o all’esterno, grossolana o sottile, inferiore o superiore, tutta la forma che è lontana o vicina, questo [fatto] (“Questo” si riferisce al senso effettivo delle tre frasi seguenti.) dovrebbe essere visto realmente con retta saggezza così: “Questo non è mio, questo non sono io, questo non è il mio sé”.
«Pertanto qui, monaci, qualunque sia la sensazione passata, futura, presente, interna o all’esterno, grossolana o sottile, inferiore o superiore, tutta la sensazione che è lontana o vicina, questo [fatto] dovrebbe essere visto realmente con retta saggezza così: “Questo non è mio, questo non sono io, questo non è il mio sé”.
«Pertanto qui, monaci, qualsiasi concetto passato, futuro, presente, interno o all’esterno, grossolano o sottile, inferiore o superiore, tutto il concetto che è lontano o vicino, questo [fatto] dovrebbe essere visto realmente con retta saggezza così: “Questo non è mio, questo non sono io, questo non è il mio sé”.
«Pertanto qui, monaci, gli impulsi, quali che siano, passati, futuri, presenti, interni o all’esterno, grossolani o sottili, inferiori o superiori tutti gli impulsi che sono lontani o vicini, questo [fatto] dovrebbe essere visto realmente con retta saggezza così: “Questo non è mio, questo non sono io, questo non è il mio sé”.
«Pertanto qui, monaci, qualsiasi percezione passata, futura, presente, interna o all’esterno, grossolana o sottile, inferiore o superiore, tutta la percezione che è lontana o vicina, questo [fatto] dovrebbe essere visto realmente con retta saggezza così: “Questo non è mio, questo non sono io, questo non è il mio sé”.
«Vedendo così, monaci, il nobile discepolo istruito è disincantato dalla forma, è disincantato dalla sensazione, è disincantato dal concetto, è disincantato dagli impulsi, è disincantato dalla percezione. Disincantato, si distacca. Grazie al distacco è liberato. Quando è liberato, [in lui] sorge il riconoscimento: “liberato”. Così comprende: “La [necessità della] nascita è venuta meno. La vita spirituale è compiuta. Ciò che deve essere fatto è stato fatto. Non ci sarà un altro [ritorno] a questo stato [di esistenza]”». Il Beato parlò così.
Estasiati, i monaci, il gruppo dei cinque, si rallegrarono del discorso del Beato. Quando questo discorso fu pronunciato, le menti dei monaci del gruppo dei cinque, essendo senza attaccamento, furono liberate dalle impurità.
© Pema Jigdrel Ogyen Samten Ling Muni